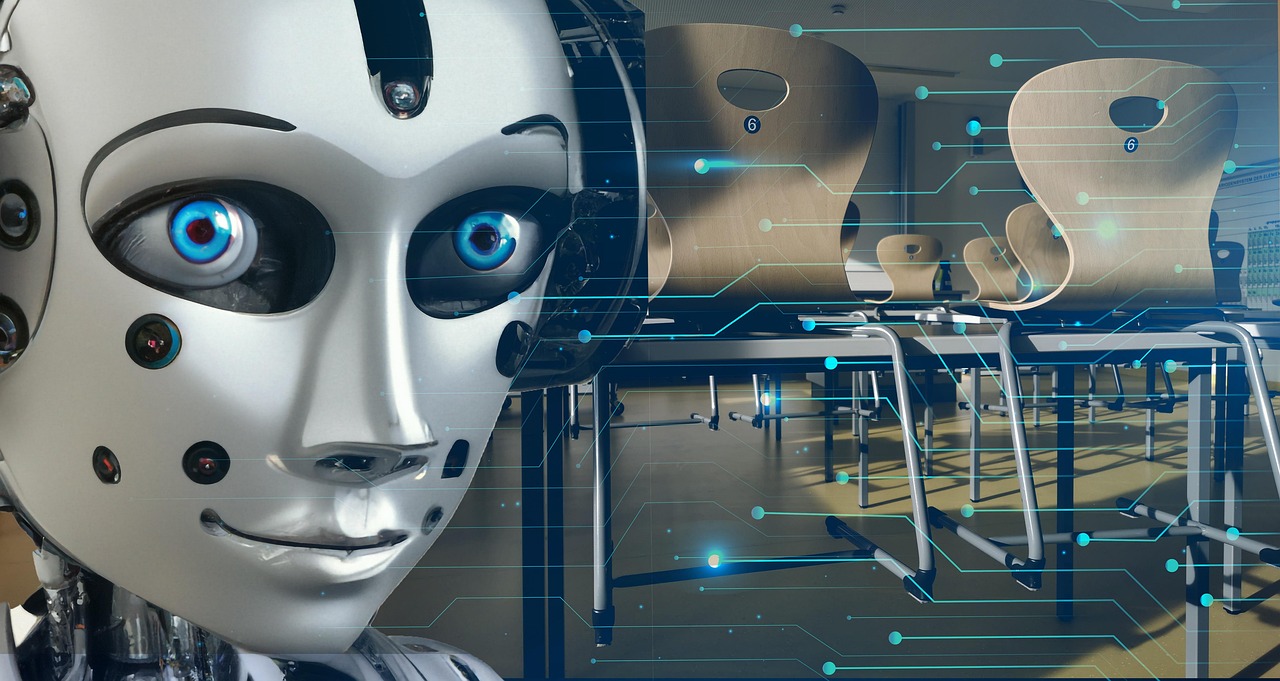Piero Lucisano, docente di Pedagogia sperimentale presso il Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione de “La Sapienza” Università di Roma e membro del Comitato scientifico di indirizzo di Campus, è sempre molto attento ai contesti della formazione, dell’educazione e, ovviamente della pedagogia. Dall’alto della sua esperienza, in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, fa una riflessione approfondita sul fenomeno del bullismo giovanile, osservando come la mancanza di responsabilità e di educazione nel discorso pubblico degli adulti possa trasformarsi in uno specchio deviato al quale i giovani, più o meno consapevolmente, possono rifarsi. “Quando un politico deride un avversario, quando un dirigente usa il sarcasmo per squalificare un’opinione, quando un giornalista spettacolarizza l’odio, quando i rapporti tra genitori e insegnanti finiscono in rissa, qualcuno guarda e impara. E troppo spesso, quel qualcuno è un adolescente”. Da qui una riflessione sul ruolo e sulla responsabilità degli adulti. L’appello è stato pubblicato sull’ultimo numero di Education 2.0, la rivista online fondata da Luigi Berlinguer.
Per una responsabilità educativa di chi ha voce, potere e rappresentanza
In questi anni il fenomeno del bullismo giovanile è esploso in modo impressionante, i giornali riportano ogni giorno episodi che coinvolgono ragazzi e talvolta anche bambini. Ci sono migliaia di ricerche sul bullismo giovanile e sul bullismo nella scuola. Ma il bullismo non è un problema solo dei giovani.
È un problema che ha origine nel comportamento degli adulti e cresce in un momento storico in cui la “buona educazione” e il rispetto delle regole di comportamento vengono continuamente trasgredite.
Si è andata affermando l’idea che le buone maniere per gli adulti siano un modo ipocrita di comportarsi che limita la libertà di espressione. Così questa presunta libertà ha portato il linguaggio politico a un uso smodato di violenza verbale. L’insulto è diventato titolo da talk show, la prevaricazione e la ridicolizzazione dell’altro sono diventate strategie di consenso.
Ogni giorno assistiamo da parte di adulti e in particolare di persone che dovrebbero rappresentare i cittadini a scene di bullismo istituzionale e mediatico: toni umilianti, attacchi personali, arroganza del potere che zittisce, distorce, schiaccia. Di questi comportamenti i media si compiacciono, dando loro, pur fingendo di criticarli, spazio ed evidenza. Lo scontro verbale fa audience, il ragionamento annoia.
Così la buona educazione e le regole di comportamento sono accantonate o proposte, in questo caso, in modo veramente ipocrita solamente ai giovani. Pretendere che la scuola risolva questo problema senza leggerne le radici è condannare noi educatori a un costante fallimento. Non basta irrigidire nella scuola le regole di condotta se agli adulti non si assegna un voto di condotta e anche quando la loro condotta è fortemente trasgressiva non ci sono strumenti che aiutano a stigmatizzarla. Ancora più difficile è se chi trasgredisce ha un ruolo pubblico.
La parola pubblica e il comportamento degli adulti hanno un valore educativo.
Quando un politico deride un avversario, quando un dirigente usa il sarcasmo per squalificare un’opinione, quando un giornalista spettacolarizza l’odio, quando i rapporti tra genitori e insegnanti finiscono in rissa, qualcuno guarda e impara. E troppo spesso, quel qualcuno è un adolescente.
Stanno aumentando le aggressioni tra i giovani.
Crescono le violenze nelle scuole, nelle strade, nei social.
È un’evidenza educativa e culturale: la mancanza di educazione nel discorso pubblico educa alla sopraffazione.
Chi ha potere, oggi, sta contribuendo – con il proprio stile – a normalizzare il bullismo e il disprezzo, la violenza sui più deboli. Non si tratta solo di quegli adulti che si propongono come bulli ma anche di tutti coloro che si compiacciono o accondiscendono alla maleducazione dei più forti, di tutti coloro che esaltano la forza contrapposta alla ragione.
Non basta deplorare, combattere e cercare di limitare solo il bullismo giovanile, se al tempo stesso permettiamo a chi è forte di comportarsi al di sopra del rispetto delle regole.
Ci sono regole più codificate, le leggi nazionali e internazionali che non possono essere ridefinite solo in base a rapporti di forza.
Poi ci sono le regole della convivenza civile, della cosiddetta buona educazione che sono maturate nei secoli e che sono patrimonio comune dell’umanità.
Se quando un potente trasgredisce le regole ci limitiamo ad esprimere un disagio servile e finiamo per assecondarlo non capirà mai che anche lui è tenuto al rispetto delle regole e alla buona educazione.
È necessario trovare strategie per aiutare tutti a riconoscersi e ad accettare queste regole.
L’aver subito violenza, l’aver avuto esperienze difficili non sono scuse accettabili, abbiamo il dovere civile di liberare i bulli e i prepotenti dal loro stile di comportamento e di poter liberare la nostra società dalla violenza. Serve una mobilitazione di tutti a partire dalla comunità di coloro che sono impegnati in prima persona sulla frontiera dell’educazione. Servono ricerche non solo di tipo educativo, ma psicologiche, sociologiche, antropologiche, psichiatriche.
Serve mantenere un approccio educato ed educativo: i bulli anche adulti non vanno isolati ma aiutati a crescere, aiutati a essere membri responsabili della società civile.
Bisogna far comprendere agli adulti e in particolare a quelli che hanno responsabilità pubbliche che hanno un dovere educativo.
Hanno il dovere di promuovere rispetto, dialogo, confronto.
Hanno il dovere di non legittimare modelli relazionali violenti.
Hanno il dovere di dare l’esempio, non lo scandalo.
Questo appello chiede:
- Una svolta etica e linguistica da parte di chi opera in politica, nei media, nelle istituzioni.
- La fine dell’umiliazione come strumento di comunicazione.
- La responsabilità educativa del linguaggio pubblico come principio irrinunciabile.
- L’impegno a denunciare e isolare pubblicamente chi persevera in comportamenti di bullismo verbale, mediatico o istituzionale.
- La costruzione di una cultura democratica fondata sulla dignità, non sul dominio.
- L’impegno delle società scientifiche che si occupano di ricerca educativa a studiare il fenomeno e a valutarne gli effetti e i costi sociali e a proporre strategie per limitare questi comportamenti.
- L’impegno della comunità civile a pretendere educazione da chi ci governa e usare anche il metro dell’educazione, della riflessività, della capacità di dialogo come criterio per la scelta dei suoi rappresentanti.
Invitiamo tutti coloro che condividono questo appello a sottoscriverlo e a cercare nei propri comportamenti e nelle proprie scelte di evitare di assecondare i comportamenti di bullismo e di cattiva educazione.
Le ricerche sul bullismo giovanile ci insegnano che bisogna reagire con fermezza senza per questo assumere il comportamento del bullo, cercando invece di aiutarlo a capire che il suo comportamento deriva da paura e frustrazione e non è vincente, aiutarlo a capire che la comunità non apprezza e non accetta questi stili di comportamento. Che i suoi “successi” sono temporanei e precari. Che il rispetto e il dialogo portano pace e benessere individuale e collettivo.
Educatori, studenti, cittadine e cittadini, dirigenti, giornalisti, insegnanti, amministratori, genitori.
Facciamo rete per aiutare a comprendere che la parola è un bene comune, non un’arma.
Facciamo rete per valorizzare e sostenere la buona educazione, la gentilezza, la diplomazia, la ricerca dell’accordo, come stili di comportamento intelligente e non violento.
 Piero Lucisano, docente di Pedagogia sperimentale presso il Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione de “La Sapienza” Università di Roma
Piero Lucisano, docente di Pedagogia sperimentale presso il Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione de “La Sapienza” Università di Roma